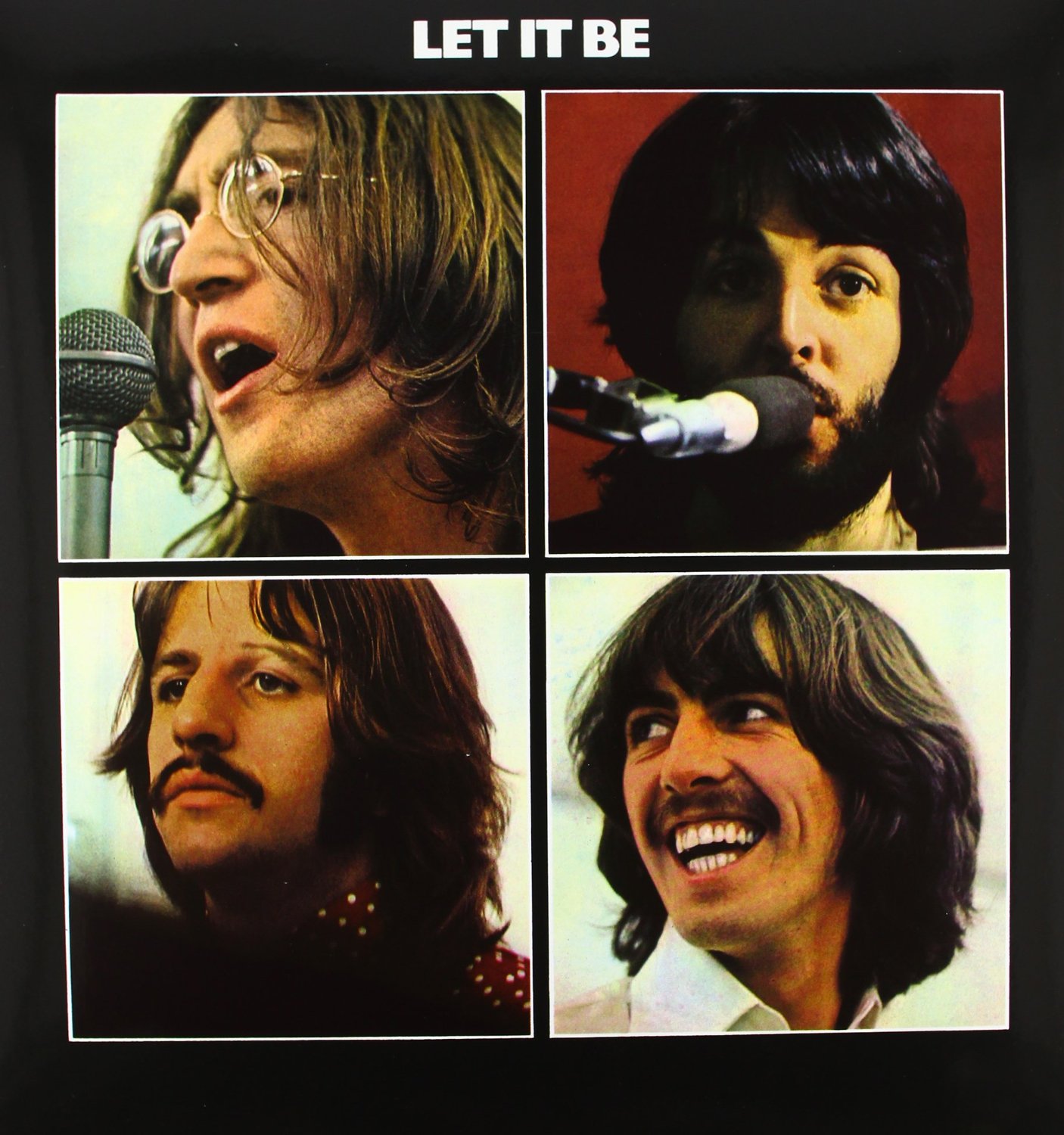In conclusione, ogni fan dei Beach Boys non può non essere felice di assistere all'uscita di cofanetti come questo e i precedenti, in quanto permettono, finalmente, di rivalutare una fase della loro carriera ingiustamente mai celebrata a dovere (ricordiamoci, ad esempio, che per gran parte degli anni '90 album come SUNFLOWER, SURF'S UP e i due qui presenti erano fuori catalogo, una follia per una band di tale importanza), ma le pecche non mancano, e l'elevato prezzo di vendita lo rende decisamente fuori portata per molti fan. Per fortuna che esiste lo streaming, altrimenti si può anche prendere in considerazione la versione a 2 CD, che include i due album e una selezione di brani bonus, ma niente dal concerto alla Carnegie Hall, quindi in sostanza ben poco di interessante, specialmente visti i già citati problemi di rimasterizzazione. Insomma, ascoltatelo su Spotify, Youtube, dove volete, ma date una chance ai Beach Boys di quel periodo, non ve ne pentirete.
martedì 13 dicembre 2022
The Beach Boys - Sail On Sailor 1972 (2022) Recensione
mercoledì 23 novembre 2022
Devin Townsend - Lightwork \ Nightwork (2022) Recensione
domenica 30 ottobre 2022
Ween -Tutti gli album dal peggiore al migliore
Detto ciò, andiamo ad analizzare la loro discografia cercando di ordinare gli album puramente in base a preferenze personali di chi scrive, premettendo che si tratta di una sequenza molto solida di album, e che quindi anche quelli in fondo alla lista hanno al loro interno qualcosa degno di nota.
11 - Friends EP (2007)
10 - La Cucaracha (2007)
9 - Pure Guava (1992)
8 - 12 Golden Country Greats (1996)
7 - Shinola Vol. 1 (2005)
6 - The Pod (1991)
5 - God Ween Satan: The Oneness (1990)
4 - White Pepper (2000)
3 - Chocolate And Cheese (1994)
2 - Quebec (2003)
1 - The Mollusk (1997)
venerdì 23 settembre 2022
Pink Floyd - Animals 2018 Remix (2022) Recensione
Questa atmosfera non era solo creata dai testi, tutt'altro che ottimistici e solari (seppur il finale di Sheep dava un tocco di speranza assente nel romanzo da cui Waters si era ispirato), ma anche dalla resa sonora dell'album, che, probabilmente, essendo stato il loro primo lavoro registrato negli allora neonati studi personali della band, i Britannia Row, risultava lontano dalla cristallina pulizia degli album precedenti, ma anche dalla pomposità data da Bob Ezrin al successivo THE WALL. Il suono era certamente più caldo, ma anche più opaco, come offuscato da qualche nuvola (pun intended), e se ciò ha di certo dato un carattere tutto particolare all'album, di fatto non lo ha aiutato a fare breccia nel cuore del grande pubblico quanto altri (poi la mancanza di potenziali brani radiofonici di certo non ha aiutato a sua volta), portando quindi ANIMALS ad essere, negli anni, più un album per appassionati e fan che un lavoro universale quanto un THE DARK SIDE OF THE MOON, senza, tuttavia, mai raggiungere totalmente lo status di "album di nicchia", sia ben chiaro.
La prima cosa che si nota è un generale "asciugamento" del suono, togliendo gran parte del riverbero precedentemente presente soprattutto sulle voci (particolarmente evidente laddove le parti vocali sono più "isolate", come in Pigs On The Wing e l'inizio di Dogs), mentre le chitarre sono tendenzialmente più presenti e, a loro volta, nitide, sia l'acustica di Pigs On The Wing che le numerose parti di elettrica solista e in armonia di Gilmour in Dogs. Altro grande cambiamento si nota per la batteria di Mason, in quanto, a fronte di un mix generale (quindi di tutti gli strumenti e delle voci) generalmente più "stretto" nello spettro stereo rispetto all'originale, le iconiche rullate sui tom sono state distribuite in modo molto ampio, dando più chiarezza, oltre ad una generale resa più spinta sia sulle frequenze basse che alte, con un risultato finale meno "inscatolato". Simile trattamento è stato fatto ai numerosi effetti sonori presenti, dal latrato dei cani al grugnito dei maiali, fino al belato delle pecore, più presenti e meglio distribuiti nello stereo. Chi, però, ci guadagna di più è probabilmente Rick Wright, le cui parti di tastiere sono ora decisamente più enfatizzate, specialmente in Sheep (si ascoltino le parti di organo Hammond ora in primissimo piano, ad esempio), mentre un simile discorso lo si può e lo si deve fare anche per le magnifiche parti di basso di Pigs (Three Different Ones), in studio suonato da Gilmour, talmente spinto di volume che a tratti si sente la cordiera del rullante di Mason vibrare.
Quindi, in definitiva, vale la pena ascoltare questo remix? Tutto dipende da quanto siete fan dell'album originale, e da quanto vorreste sentirne una versione realizzata da un punto di vista diverso, che rivela dettagli apparentemente inediti, ma non sostituisce affatto l'originale. Si tratta di un buon remix? Assolutamente. Supererà mai lo status di "curiosità"? Ne dubito.
giovedì 14 luglio 2022
Tiny Tim - Rock (1993) Recensione
Ciò ci porta agli anni '90, periodo in cui godette di una sorta di riscoperta, ed in cui pubblicò una interessante manciata di album, sempre composti da cover. Nulla, però, può essere paragonato all'album intitolato, semplicemente, ROCK. Il titolo è alquanto appropriato, in quanto effettivamente Tim si cimenta con un repertorio di natura rock quasi del tutto inedito per lui, senza però riarrangiare le canzoni nel suo peculiare stile, ma essendo invece accompagnato da una vera e propria rock band australiana chiamata His Majesty. A prima vista, guardando la tracklist, si notano solamente cinque titoli, e subito si pensa ad un EP, ma non si può essere più distanti dalla realtà. La tracklist è la seguente:
- Highway To Hell
- You Give Love A Bad Name
- Rebel Yell
- I Love Rock And Roll (The Medley)
- Eve Of Destruction
lunedì 11 luglio 2022
The Beatles - Let It Be: qual è la miglior versione?
Dopo l'uscita di THE BEATLES, o "White Album", alla fine del '68, i Beatles decisero di fare qualcosa di un po' diverso nel gennaio 1969, anche se, all'inizio, non sapevano bene cosa in particolare. Innanzitutto, ai primi di Gennaio sono andati agli studi di Twickenham con l'idea di essere filmati mentre suonavano insieme, lavorando su nuove canzoni, magari facendo delle prove per un qualche tipo di concerto, con l'assistenza di George Martin, Glyn Johns e una troupe di cameraman diretta da Michael Lidsay-Hogg. L'obiettivo doveva essere quello di suonare i nuovi brani insieme dal vivo in una stanza, quindi senza nessuna grande produzione di alcun tipo, in contrasto con i loro album più recenti. Quello che è successo ormai non è un mistero, grazie al film Let It Be del 1970 e, soprattutto, alla serie Get Back di Peter Jackson del 2021, tuttavia, per farla breve: hanno provato a Twickenham per un po', George Harrison se ne è andato per frustrazione dopo qualche giorno, si sono riuniti di nuovo a Savile Row, George è tornato, hanno chiamato Billy Preston come tastierista, poi, alla fine, hanno deciso di fare un concerto sul tetto, hanno registrato qualche altra canzone il giorno dopo, e poi hanno praticamente chiuso il progetto. Dopo di che sono andati oltre molto rapidamente e, da fine Febbraio, hanno iniziato a lavorare su ABBEY ROAD, mentre Glyn Johns ha lavorato su un paio di possibili versioni di un album poi chiamato GET BACK, tratto da quelle session di gennaio, entrambe scartate dalla band. Hanno quindi deciso di pubblicare un paio di canzoni di quelle session, "Get Back" e "Don't Let Me Down", come lato A e B di un singolo ad aprile, mentre ABBEY ROAD esce a settembre, Lennon chiede quindi a Phil Spector di assemblare un'altra versione del possibile album da quelle registrazioni, l'album cambia titolo in LET IT BE ed esce nel maggio 1970, insieme al film e a un libro. Non è un mistero che a McCartney non piacesse la versione dell'album realizzata da Spector, e questo non ha aiutato in quello che è stato un periodo molto difficile per i Beatles, che alla fine ha portato alla fine definitiva un mese prima dell'uscita dell'album.
Nel corso degli anni abbiamo avuto quattro versioni ufficiali di LET IT BE, senza contare i bootleg, quindi potrebbe essere un po' complicato per il fan occasionale sceglierne una da ascoltare (sebbene la versione originale sarà sempre storicamente importante e fondamentale), soprattutto data la natura del progetto e l'ormai ampia documentazione delle session, insieme a innumerevoli diverse take di singoli brani tra cui scegliere. Proviamo a vedere cosa abbiamo nel dettaglio.
Let It Be (1970)
La versione originale dell'album è prodotta da Phil Spector, ed è uno strano mix di una produzione molto pomposa (il suo famoso "wall of sound") su alcune tracce, e un approccio molto semplice su altre, a cui va aggiunta l'inclusione di brevi spezzoni di dialoghi in studio tra le canzoni. Quindi, da un lato, c'è "The Long And Winding Road" con archi e coro, e dall'altro c'è l'improvvisata "Maggie Mae", o un frammento di "Dig It", una jam in studio. Il risultato è un po' discontinuo, ma in qualche modo funziona. Per qualche ragione, "Don't Let Me Down" non è stata inclusa in questa versione dell'album, anche se è stata effettivamente pubblicata come singolo nel 1969.Alla fine, ad alcuni piace la peculiare produzione che Spector ha portato su alcune delle canzoni, mentre altri la odiano (incluso McCartney), affermando che è in totale contrasto con l'idea del "ritorno alle origini" che era alla base del intero progetto. Detto ciò, Spector è stato chiamato a lavorare sui brani senza che gli fosse detto esattamente cosa fare, e ha semplicemente fatto il suo lavoro nel suo stile; quindi, anche se il risultato potrebbe suonare discontinuo, non coerente con l'idea iniziale del progetto, e forse anche diverso dal solito "sound" dei Beatles in quanto non prodotto da George Martin), quello che ha fatto è storicamente importante e non può essere sottovalutato.
Tracklist in dettaglio:
- Two Of Us: a quanto pare quello che sentiamo è la "take 12", registrata il 31 gennaio.
- Dig A Pony: questa versione è tratta dal concerto sul tetto del 30 gennaio: Spector ha deciso di abbassare il pianoforte di Preston nel mix e tagliare la parte "all I want is.." all'inizio e alla fine della canzone.
- Across The Universe: la versione base è stata registrata il 4 febbraio 1968, con un sitar, una tamboura e un coro di ragazze, e quella versione è uscita come singolo nell'ottobre 1969. Tuttavia, dal momento che si vedono i Beatles mentre provano la canzone nel film , qualcuno ha pensato che avesse senso averlo anche nell'album, quindi, in quanto non sono mai arrivati a una versione finale della canzone in quelle session, Spector ha ripescato la traccia base del 1968, ha aggiunto archi e coro e l'ha rallentata, quindi abbassandola da Re a Re bemolle, il 1 aprile 1970.
- I Me Mine: Questa canzone è, ancora una volta mostrata nel film, ma la registrazione vera e propria è stata realizzata solamente il 3 gennaio 1970, senza John Lennon. La take principale utilizzata è la 15, da cui Spector ha copiato e incollato un verso alla fine per renderla più lunga, e ha aggiunto alcuni archi il primo aprile 1970.
- Dig It: un breve frammento di una jam in studio nata il 24 gennaio, anche se questa versione specifica è del 26.
- Let It Be: la take principale è la 27A del 31 gennaio 1969. Quando decisero di pubblicarla come singolo nel 1970, George Martin scrisse e registrò un arrangiamento di ottoni e nuove sovraincisioni di un coro (di McCarney, sua moglie Linda e Harrison), piano elettrico e nuove percussioni. Per l'album, Spector ha utilizzato un altro assolo di chitarra registrato da Harrison nell'aprile 1969 (riconoscibile per non essere stato suonato tramite un altoparlante Leslie, come i precedenti) e ha alzato l'arrangiamento degli ottoni di Martin nel mix.
- Maggie Mae: una vecchia canzone tradizionale improvvisata e registrata molto velocemente il 24 gennaio, questo è il terzo tentativo assoluto.
- I've Got A Feeling: quella che sentiamo è la prima esecuzione completa di questa canzone sul tetto il 30 gennaio 1969 (l'hanno suonata due volte quel giorno).
- One After 909: questa versione è, ancora una volta, dal concerto sul tetto, l'unica take che hanno suonato lì.
- The Long And Winding Road: il brano base è stato registrato il 26 gennaio 1969, a cui Spector ha aggiunto gli archi (arrangiati da Richard Hewison), un coro e un'ulteriore parte di batteria di Ringo il primo aprile 1970.
- For You Blue: la traccia base è la take 6 del 26 gennaio 1969, Spector ha deciso di includere una nuova traccia vocale principale registrata da Harrison l'8 gennaio 1970, e di omettere la sua traccia di chitarra acustica dall'intera canzone, mantenendola solo per l'introduzione.
- Get Back: quella che sentiamo è la take 11 del 27 gennaio 1969. La coda che registrarono il giorno successivo fu usata solo nella versione del singolo.
Let It Be... Naked (2003)
- Get Back: un semplice remix della stessa take usata sia per il singolo che per l'album originale, sempre senza coda, ma anche senza dialoghi.
- Dig A Pony: solo un remix della stessa take dal tetto usata nell'album originale (sempre con la parte "all I want is..." tagliata), senza dialoghi e false partenze.
- For You Blue: ancora una volta, la stessa versione dell'album originale, con la nuova traccia vocale del gennaio 1970, ma questa volta con la chitarra acustica di George presente nel mix per l'intera canzone.
- The Long And Winding Road: questa è probabilmente la traccia che suona in modo più diverso, poiché non solo hanno eliminato le sovraincisioni, ma hanno anche deciso di utilizzare una take completamente diversa. Quella che sentiamo è in realtà la take 19 del 31 gennaio 1969, l'ultima volta che i Beatles hanno suonato la canzone, e anche la stessa versione che vediamo nel film LET IT BE.
- Two Of Us: una versione remixata di quella ascoltata nell'album originale, senza dialoghi.
- I've Got A Feeling: per questa canzone hanno deciso di combinare le due take del concerto sul tetto, invece di usare solo la prima come nell'album originale, probabilmente per ottenere una versione dal suono più "perfetto".
- One After 909: una versione remixata dell'unica take fatta sul tetto, la stessa utilizzata nell'album originale.
- Don't Let Me Down: questa canzone non è stata inclusa nell'originale LET IT BE, ma è stata pubblicata come singolo nel maggio 1969, utilizzando una versione registrata il 28 gennaio con l'aggiunta di take vocali registrate nel febbraio dello stesso anno. Questa specifica versione, invece, è una combinazione di due diverse take del concerto sul tetto del 30 gennaio 1969.
- I Me Mine: un remix della stessa versione più lunga realizzata da Spector nel gennaio 1970, però senza l'orchestra.
- Across The Universe: qui viene utilizzata la stessa take del 1968, ma in questo caso la canzone è presentata alla velocità e alla tonalità originali, senza l'orchestra, con solo voce, chitarra, percussioni leggere e la tamboura di George, con un tocco di riverbero crescente man mano che la canzone avanza.
- Let It Be: qui viene utilizzato un remix della take 27A del 31 gennaio (stessa take dell'album originale), senza alcun tipo di sovraincisione del 1970, originariamente presenti sia nel singolo originale che nell'album, e con l'ennesimo assolo di chitarra diverso, questa volta dalla take 27B di quello stesso giorno.
Let It Be (Giles Martin 2021 Remix)
Get Back (Glyn John 1969 Mix)
- One After 909: questa è la stessa take usata in ogni versione dell'album, quella del concerto sul tetto, e qui è mixata in modo diverso, con uno stereo più ampio.
- I'm Ready (Rocker) / Save the Last Dance for Me / Don't Let Me Down: un medley di qualche jam in studio con un frammento di "Don't Let Me Down" improvvisato alla fine, una breve traccia che dà il primo assaggio di quelle session, registrato il 22 gennaio 1969.
- Don't Let Me Down: una versione più rilassata della canzone, una delle prime take con Billy Preston al piano elettrico, registrata il 22 gennaio 1969.
- Dig a Pony: registrata ancora il 22 gennaio come i brani precedenti, questa volta mantiene la sezione "all I want is..." all'inizio e alla fine.
- I've Got a Feeling: un altro brano del 22 gennaio, suonato proprio dopo "Dig A Pony", una versione molto energica che purtroppo si interrompe prima dell'ultima strofa, e finisce lì. Questo è probabilmente uno degli esempi più evidenti di alcune discutibili scelte di take fatte da Jones: sebbene abbia scelto un'ottima performance, il finale mancante è un difetto molto evidente.
- Get Back: questo è in realtà la stessa take e mix della versione del singolo del 1969 (quindi la stessa usata anche in ogni versione dell'album), registrata il 27 gennaio, senza la coda del giorno successivo.
- For You Blue: la stessa versione usata per tutte le altre uscite, solo con la traccia vocale originale di quella stessa take (non quella ri-registrata nel gennaio 1970), sempre con la chitarra acustica tenuta nel mix.
- Teddy Boy: una canzone di Paul McCartney che i Beatles hanno provato in queste session, ma che alla fine l'ha finita da solo per il suo primo album da solista nel 1970. Questa versione, tutt'altro che definitiva, è del 28 gennaio 1969.
- Two of Us: questa è la versione finale registrata il 24 gennaio 1969, il primo giorno in cui decisero di provare un arrangiamento acustico del brano, ed è leggermente più lenta e imprecisa nelle parti canore rispetto alla versione che tutti conosciamo.
- Maggie Mae: la stessa versione di LET IT BE, solo con una dissolvenza alla fine.
- Dig It: questa è la stessa jam presentata su LET IT BE con lo stesso nome, ma qui abbiamo la take completa di 4 minuti invece di soli 40 secondi.
- Let It Be: la stessa take usata sul singolo e tutte le diverse versioni dell'album (27A del 26 gennaio), con lo stesso assolo del singolo e senza sovraincisioni di sorta.
- The Long And Winding Road: sempre dal 26 gennaio, come in ogni versione dell'album a parte ... NAKED, senza sovraincisioni, solo un tocco di riverbero aggiunto.
- Get Back (Reprise): la coda del 28 gennaio.
giovedì 26 maggio 2022
Journey - Escape (1981) Recensione
ESCAPE è probabilmente la perfetta rappresentazione del pop-rock anni '80, con tutti i suoi alti e bassi a seconda dei gusti dell'ascoltatore, ed è anche il momento in cui il mondo si rese definitivamente conto del talento vocale di Perry, qui al suo indiscutibile apice. Fin da subito si mette in chiaro come stanno le cose, con la celeberrima Don't Stop Believin' ad aprire le danze, caso particolare di tipico pezzo da stadio in cui, tuttavia, l'iconico ritornello arriva una sola volta, alla fine. Qui ogni singolo elemento è dosato alla perfezione, dagli accordi di piano iniziali, all'iconica performance vocale di Perry, fino ai centellinati interventi chitarristici di Neal Schon, il tutto aiutato da una cristallina e potente produzione (merito di Mike Stone e Kevin Elson) che farà da base a gran parte delle uscite dello stesso genere che seguiranno negli anni successivi. Se da un lato aprire un album con questo brano è una scelta vincente, dall'altro c'è il concreto rischio che il resto sfiguri al confronto, non essendoci, di fatto, altri brani paragonabili al primo in termini di fama. Detto ciò, il solare rock di Stone In Love e la vivace Keep On Runnin', la quasi-ballad Who's Crying Now e la vera e propria ballad Still They Ride godettero di un buon successo, e a loro volta rientrano in pieno nei canoni AOR, dimostrandosi brani magnificamente composti ed arrangiati. L'unico altro brano in grado di competere (quasi) con Don't Stop Believin' in termini di fama è la conclusiva Open Arms, prototipo di ballad commovente al piano perfetta per far sfoderare gli accendini al pubblico, oltre ad una ulteriore, perfetta, occasione per Perry di mettersi in mostra con la sua magnifica voce.
ESCAPE proietta i Journey verso un indiscutibile successo planetario, che continuerà coerentemente con il successivo FRONTIERS, dalle sonorità un po' più dure, e RAISED ON RADIO, più vicino ad un album solista di Perry (infatti sarà proprio lui a produrlo) ma con altre ottime canzoni al suo interno, prima dello scioglimento della band, interrotto solo a metà anni '90. Dopo l'uscita di ESCAPE non si contano le band rock, di cui molte con già una carriera già avviata nel corso degli anni '70, che si accodarono a questo genere macinando hit su hit, da supergruppi come Foreigner e Asia ai già comunque affermati Toto, i tanto odiati anni '80 (tranne quando tornano di moda, come di questi tempi, allora non sono più odiati, e tutti giù con mullet e giacche con le spallone, perchè viva l'identità) prendono definitivamente forma.
domenica 22 maggio 2022
Wizzard - Introducing Eddy and the Falcons (1974) Recensione
You Got Me Runnin' guarda invece ai gruppi vocali dei primi anni '60, dalle Ronettes ai Four Seasons, con largo uso di acuti coretti, mentre Dun Lotsa Cryin Over You è, ovviamente, un tributo a Elvis Presley. Ciò che segue sono forse i due brani più di spicco dell'intero lavoro, probabilmente in quanto i più vicini allo stile che lo stesso Wood ha sviluppato in quegli anni; This Is The Story Of My Love (Baby) è un brano pesantemente spectoriano, non lontano stilisticamente dai precedenti singoli dei Wizzard, ed il suo fallimento commerciale come singolo tutt'oggi rimane un mistero. Le tipiche caratteristiche delle produzioni di Spector, soprattutto il famoso wall of sound, sono qui riprodotte in modo totalmente realistico e fedele, e il brano è tra le cose più memorabili composte da Wood. Segue invece una vera e propria riscrittura del classico Runaway di Del Shannon, altro eroe sia di Wood che dell'ex compagno di band Jeff Lynne; la sensazione all'ascolto di questo brano, Everyday I Wonder, è molto particolare, in quanto a tratti sembra di ascoltare una cover, ma proprio quando si pensa che il brano debba andare in un certo modo, ecco che devia altrove, cambiando tempo e sonorità. L'iconico assolo di Clavioline di Runaway è qui riproposto molto simile, una volta all'oboe, un'altra al sax e poi con un sintetizzatore, ed in generale, nonostante la sua natura derivativa, si tratta di un gran bel brano (come d'altronde lo è anche la sua fonte di ispirazione). Segue un tributo a Gene Vincent con Crazy Jeans e un'altra vera e propria riscrittura, questa volta di Oh Carol di Neil Sedaka, con Come Back Karen (pare che lo stesso Sedaka passò dagli studi durante le registrazioni e fu divertito e onorato del tributo), per poi concludersi con il brano forse più vicino alla pesante distorsione sonora del precedente BREW, We're Gonna Rock 'n' Roll Tonight, festosa e rumorosa conclusione dell'album dal sapore, appunto, rock 'n' roll. Se si acquista la recente versione in CD pubblicata dalla Esoteric (dopo che l'album è stato irreperibile per decenni) si può godere di cinque brani aggiuntivi, tutti tratti da dei singoli: il mancato classico Rock 'n' Roll Winter, i lati b strumentali dal sapore jazz Dream Of Unwin, Nixture e Marathon Man (il perché di questo stacco stilistico lo vedremo tra poco) e la divertente Are You Ready To Rock, altro canonico brano rock 'n' roll che non avrebbe sfigurato nell'album, con una sorprendente conclusione dominata dalla cornamusa.
EDDY AND THE FALCONS è senza alcun dubbio l'album più commerciale e di facile ascolto dei Wizzard, lontano da BREW senza però stravolgerne il sound, ed è un'ulteriore dimostrazione del talento compositivo e interpretativo di Roy Wood, oltre che della sua incredibile versatilità, anche e soprattutto a livello vocale. Si tratta, tuttavia, anche di un album abbastanza divisivo, in quanto gli amanti della vena più eclettica e sperimentale di Wood potrebbero rimanere delusi di fronte ad un album di "canzoni vecchio stile", mentre chi, come me, quel tipo di canzoni le adora, non potrà non apprezzarne questo originale e riuscito tributo, soprattutto in quanto molti altri album analoghi dell'epoca (come ROCK 'N' ROLL di John Lennon) proponevano vere e proprie cover, riarrangiate o meno, mentre qui siamo di fronte a brani originali. Fatevi un favore e ascoltate questo album, la sua leggerezza e vivacità non può lasciarvi totalmente indifferenti.





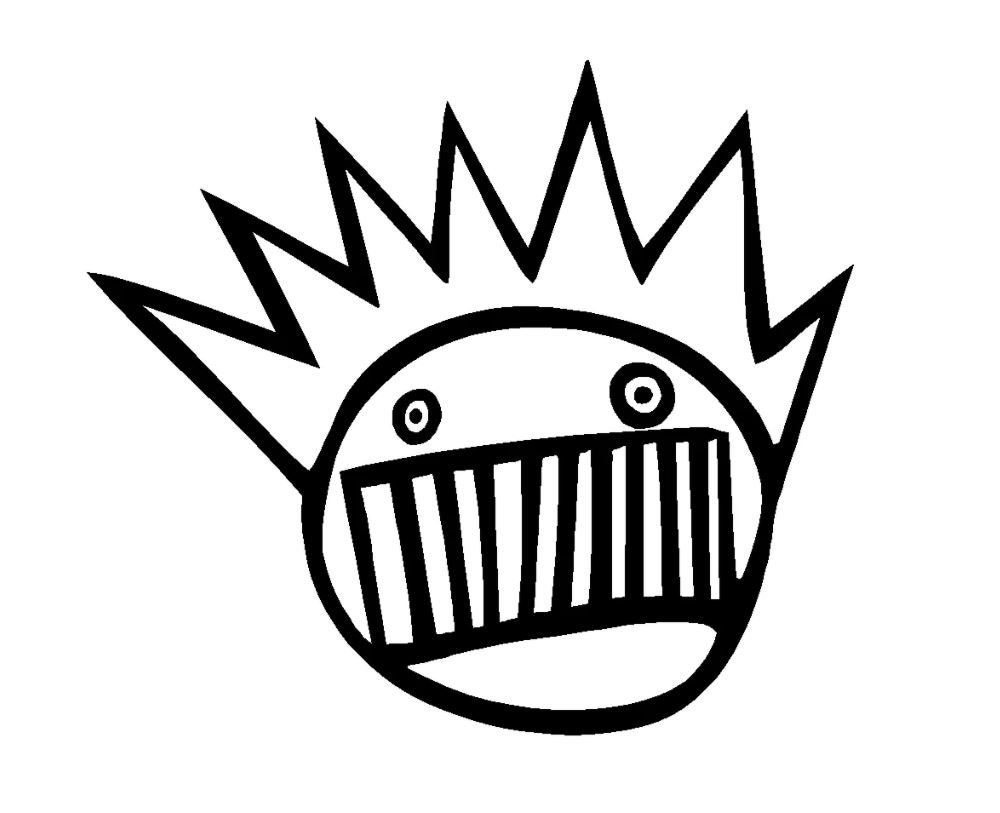












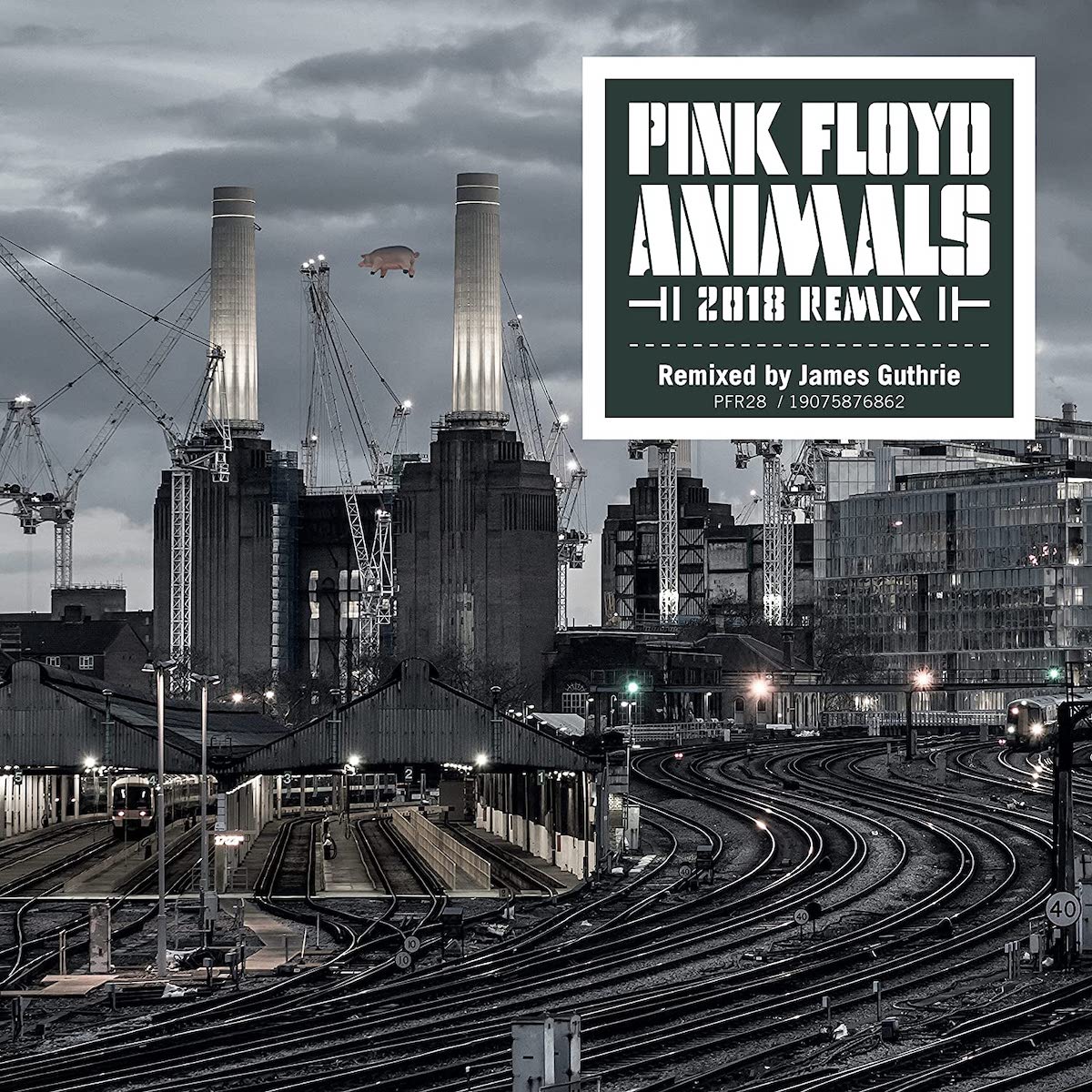


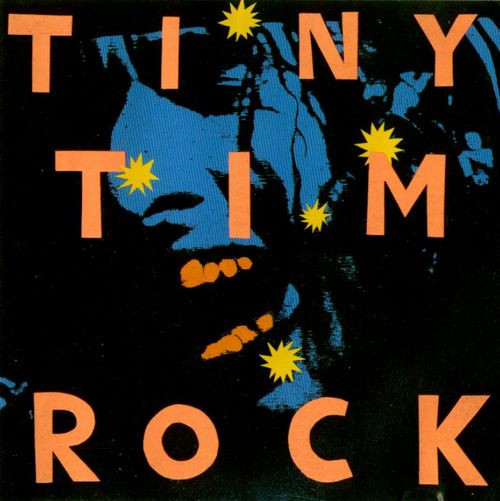

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/70195463/3b8d80123ece261ca2fe9d12c874f65e_2304x1716_8ae9c5a3.0.jpeg)